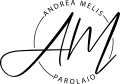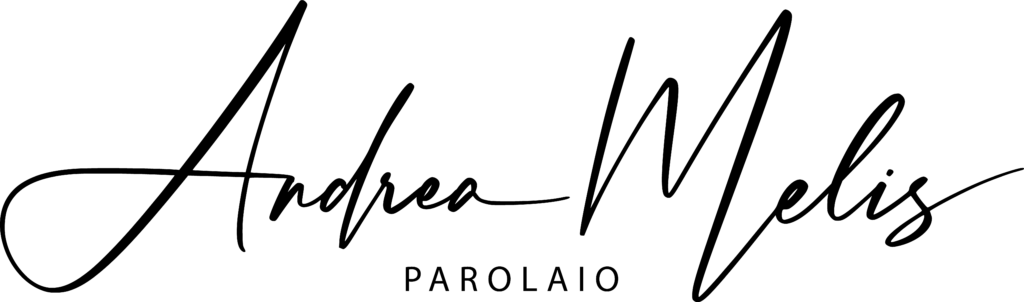Biografia in forma di racconto.
Ho quasi sempre sbagliato tutto. Fin dagli studi. Sono nato a Cagliari nel 1979 e ho fatto l’Istituto Tecnico per Geometri pensando fosse una variante del Liceo Artistico. Ma in programma c’erano solo scatole quadrate tutte uguali e righe dritte da disegnare.
All’esame di maturità presi il massimo dei voti in italiano scritto e orale, ma sbagliai una formula da prima superiore nel compito più importante: il calcolo di un plinto in cemento armato. La commissione d’esame era perplessa. Il presidente mi chiese sottovoce cosa avrei voluto fare da grande. Quando gli risposi “lo scrittore”, pretese gli giurassi solennemente davanti a tutti che non avrei mai costruito nulla: né una casa né una cuccia per cani. Lo giurai. Mi diedero sessanta/sessantesimi.
Mantenni la promessa andando alla facoltà di Lettere, ma senza basi di latino e greco mi arenai lungo il percorso. Anche ripiegando su studi antropologici, riuscii con fatica a dare la metà degli esami, e a un certo punto mi dovetti accontentare di aver acquisito lo stretto indispensabile: non la laurea, ma l’aver imparato a imparare. D’altronde a me interessava soprattutto scrivere. Cosa che già cominciai a fare sulle pagine della Cultura del Quotidiano La Nuova Sardegna, fin dal lontano 2001, intervistando proprio scrittori, musicisti e coprendo reportage su eventi e festival letterari.
Così mi tolsi di mezzo, sebbene con in tasca dieci esami con trenta di media, il mio dovere verso lo Stato espletando la leva obbligatoria, che svolsi come servizio civile. E feci bene perché cominciai a imparare a fare il grafico, e poco dopo arrivò per caso, tramite un annuncio sul giornale, la mia prima e a tutt’oggi unica assunzione: un contratto di lavoro indeterminato in un call center.
Credere che il call center sarebbe stato un lavoro provvisorio in attesa di meglio fu il mio ultimo errore. Dopo quindici anni ero ancora lì che rispondevo al telefono, sulla soglia dei quaranta, con meno capelli, più pancetta, una mutuo, ma anche una splendida moglie e una figlia meravigliosa.
Eppure non ero felice.
Scrivere era stata sempre la mia pulsione. Anche durante gli anni del call center, non l’avevo mai abbandonata. Nel 2006 avevo partecipato alla fondazione del Collettivo Sabot, di cui feci parte per quasi dieci anni. Come romanziere noir partecipai alla scrittura di due importanti romanzi inchiesta: Perdas de Fogu (Edizioni e/o – 2008) e l’Albero dei Microchip (Edizioni Ambiente – 2009) e nel mezzo tantissimi racconti personali e collettivi su giornali e riviste, nazionali e stranieri.
Sempre mentre rispondevo al telefono prima per 8 ore al giorno e poi, in un primo tentativo di salvarmi la vita, per 6 ore al giorno.
E fu allora che mi resi conto di non voler essere un romanziere. Certo, apprezzavo il ruolo di reificazione della morte e del male della letteratura di genere, e non ero tipo da happy end. Ma sentivo l’assenza di luce ovunque. E cominciai a pensare a un progetto di scrittura che reificasse anche la bellezza nei piccoli oggetti, e la poesia del quotidiano, qualcosa che costituisse se non un finale felice almeno un “happy start” per un nuovo inizio. D’altra parte ogni giorno, al call center, constatavo a mie spese che il futuro sarebbe stato di chi nella brevità avrebbe raggiunto la profondità degli animi.
Al call center, infatti, eravamo mille duecento ragazzi che invecchiavano ogni tre minuti – il tempo medio concesso per risolvere ogni chiamata – e respiravamo (o fumavamo, bevevamo, mangiavamo…) solo ogni quindici minuti di pausa, cronometrata al secondo, ogni due ore di lavoro: quindici minuti di riposo, più o meno ogni cinquanta telefonate.
Contemporaneamente, nel mondo “lì fuori” dal call center, con i social network e le app di messaggistica, vedevo le persone regredire a stazioni telegrafiche, a geroglifici e iconcine, a comunicazioni fatte di frasi e concetti brevi, spezzati, e faccini sorridenti o tristi. Più tristi che felici.
Mi scoprivo ogni giorno circondato da monadi di infelicità, e la cosa era piuttosto inquietante. Quotidianamente dialogavo con centinaia di voci di ogni angolo del Paese e di ogni estrazione economica e sociale: con tutti, il minimo comune denominatore era l’analfabetismo dei sentimenti, la frustrazione, la solitudine.
Quando un vecchio ti chiama la notte di Natale per lamentarsi di due centesimi in più in fattura, comprendi che non è un problema amministrativo: è solitudine. Quell’uomo, a Natale, cerca disperatamente un’anima viva con cui parlare.
Quando una casalinga ti confessa di non conoscere abbastanza nomi di città per farti lo spelling del suo cognome, non è un problema di cultura o geografia: è solitudine. Significa che non è mai uscita dal suo minuscolo mondo, dal suo piccolo paesello.
Quando un maschio single, adulto, paga l’abbonamento per il suo cane, mentre lui detesta la televisione, non è follia: è solitudine. Significa avere un disperato bisogno di fare felice qualcuno, di avere accanto amore, anche se a quattro zampe.
Quando gli italiani ti chiedono più calcio che cinema e, ancora più del calcio, vogliono porno e, più del porno, pretendono cartoni animati, non è un problema di ignoranza, ma di futuro: significa che stiamo allevando figli con vizi più grandi dei nostri.
A metà giugno del 2017, esattamente un anno fa, cominciai a non star bene. Sistema linfatico gonfio, febbriciattola costante, nessuna reazione alle cure.
In attesa degli esami, temetti il peggio. E feci il classico bilancio di una vita. Avevo un posto fisso, ma ero infelice. Avevo l’amore, ma ero infelice. Avevo una casa, ma ero infelice. Avevo tutto quello che serve a vivere, ma non riuscivo a sopravvivere più al richiamo dei miei sogni.
Scrissi una poesia di due righe:
“E poi c’è questo nostro tempo in cui di sogni non si vive, ma senza si muore”.
E l’appesi sul monitor del computer.
E riflettei come i sogni fossero ormai diventati bisogni: era tempo di chiuderla con la vita del turnista, e con quel lavoro che le notti, le domeniche e i giorni di festa comandata mi teneva lontano dalla mia famiglia, cioè da coloro per cui paradossalmente accettavo il ricatto del posto fisso. Era ora di farla finita con lo stipendio da mille euro al mese ma senza alcuna possibilità di carriera, cosa che mi avrebbe tenuto comunque sulla soglia della povertà per tutta la vita. Dovevo farla finita con l’alienazione ripetitiva di un mestiere che mi causava attacchi d’ansia al solo pensiero di alzarmi al mattino.
Dovevo decidere, poco prima del bivio dei quarant’anni, se imboccare la strada degli azzardi o quella dei rimpianti.
E soprattutto ero stufo di fingere di non sapere che il mondo intorno a me, più che aver bisogno di sapere come riavviare un decoder, o come poter risparmiare con qualche promozione sull’abbonamento, necessitasse invece di umanità, di bellezza, di poesia.
A quel punto, la prima cosa che giurai, fu che non sarei tornato al call center. Mai più.
Le analisi rivelarono una brutta mononucleosi, ma niente di grave. Non sarei morto, questa volta, ma avrei dovuto stare forzatamente in casa per due mesi.
Raccolsi le mie quattrocento poesie, scritte quasi per gioco su Facebook, tutte di poche righe, e decisi che, dopo cinque anni di silenzio dopo l’avventura come romanziere noir, avrei fatto un libro di poesie.
Accanto alla mia frase sui sogni ne avevo un’altra di Wislawa Szymborska che tanto mi aveva fatto riflettere: “Preferisco la ridicolaggine di scrivere poesie a quella di non scriverne”.
Che mi diede il coraggio che serviva. Non pensai nemmeno di cercare un editore. Doveva essere la mia fuga personale, silenziosa e segreta. Come nel film tratto dal capolavoro di Stephen King, “Le ali della Libertà”.
Scelsi una copertina irriverente e insolita: un cane nero che cagava un cuore rosso, su sfondo giallo. E non ebbi dubbi sul titolo: #Bisogni. Poesie urgenti d’amore, di lotta e di sogni.
Lavorai al progetto come un forsennato. Già il 1 luglio 2017, lanciai un crowdfunding sul portale Produzioni dal Basso http://www.produzionidalbasso.com/project/bisogni-poesie-urgenti-d-amore-di-lotta-e-di-sogni/ e, non potendo dedicarmi al mare come qualsiasi altro mio conterraneo sardo fa d’estate, da quel confino casalingo misi tutto il mio impegno nella promozione delle mie piccole poesie piene di luce e speranza.
Tanti artisti si appassionarono a questa scommessa e decisero di puntare con me. Così, per trentun giorni, uscirono video, quadri, illustrazioni, canzoni e performance di giocolieri e attrici ispirati alle mie poesie.
Raccolsi in appena un mese oltre tremila euro di donazioni dai miei lettori, che preordinarono duecento cinquanta copie. Un vero e proprio anticipo di fiducia con cui mi auto-produssi il libro sul portale di Kataweb – IL MIO LIBRO. Quando ad ottobre arrivarono le successive duecento copie, ero in congedo ormai da quattro mesi e mi domandavo per quanto tempo ancora quegli scatoloni avrebbero ingombrato il salone. Ormai avevo finito i parenti, le zie e gli amici.
Invece attraverso un passaparola carbonaro via Facebook, via sms, via whatsapp si innescò un meccanismo irripetibile che mi portò a ricevere ogni giorno decine di richieste di libri da lettori di tutta Italia e di mezza Europa: a un mese dal Natale 2017 avevo già dovuto ristampare oltre mille copie. Nella prima settimana di uscita (dal 21 al 28 ottobre) #Bisogni fu premiato in quanto risultò il più venduto su oltre 400 mila autori pubblicati nel portale, ricevendo una settimana di pubblicità premio su Repubblica.it. Trascorrevo le giornate a scrivere dediche, incollare francobolli e correre in posta a spedire pacchetti. Ho conservato tutte le ricevute. E le notti si moltiplicavano gli inviti ai reading nei pub, nelle case e le presentazioni agli eventi più svariati, finché non venni invitato anche “alla luce del sole”, nel tavolo dei grandi: e cominciai a fare presentazioni nelle librerie della mia regione e non solo. Cosa rara per un libro senza editore.
Ricevevo in cambio riscontri che mi lasciavano sbalordito: lettere, ringraziamenti, attestati di affetto e speranza, e una grande energia che il libro, come un oggetto magico, continuava a scatenare. I contatti virtuali uscivano dai Social, e si materializzavano in persone e fatti che cominciai a raccontare sul mio profilo Facebook che intanto cresceva di migliaia di lettori, e che appassionavano e incuriosivano attraverso una sorta di diario fatto di piccoli post chiamati “miracoli”, perché tali li reputavo.
Un signore di Napoli si innamorò delle mie poesie e acquistò decine di copie per donarle alle biblioteche pubbliche e ai suoi amici, quasi come un novello mecenate.
La madre del fondatore di quello che è oggi il più importante e innovativo gruppo editoriale sul web mi scrisse una lettera bellissima.
Una figlia mia conterranea mi svelò del padre che si era come risvegliato, in quelli che avremo poi scoperto essere gli ultimi giorni di una vita resa silenziosa dalle nubi dell’Alzheimer, grazie alle mie poesie. Quando poi lui morì, lei e i suoi fratelli mi chiesero di poterlo seppellire con la foto di una copia del mio libro in mano, e al funerale si alternarono a leggere una mia poesia.
Una madre mi raccontò che il figlio, malato di epilessia Rolandica, dormiva sereno da quando ogni notte aveva iniziato a leggergli una mia poesia come buonanotte, e che ormai non aveva una crisi da oltre tre mesi. Mi mandò le analisi attribuendo il merito alle mie poesie. Io mi schermii, ma capii che, anche se era improbabile che delle poesie avessero poteri taumaturgici, di sicuro male non facevano.
Molte giovani studentesse iniziarono a postare mie poesie nei loro profili social, e a scrivermi che avevano le mie frasi nei loro appunti universitari, che si passavano il libro sottobanco insieme alle gomme da masticare indurite dalla noia. E pure le insegnanti mi scrivevano, a testimonianza che la poesia non conosce confini generazionali né geografici, per invitarmi nelle scuole.
In breve tempo fui invitato a molte feste di laurea, mostre, eventi teatrali, e reading nelle case private e vari docenti mi invitarono a parlare di poesie ai loro studenti, che fossero licei o istituti tecnici.
Il riscontro cominciava a essere misurabili: dopo essere stato messo in Homepage come esempio di uno dei migliori crowdfundig editoriali dallo staff del portale Produzioni dal Basso, Il libro, nelle prime settimane di uscita, era anche stato premiato come il più venduto d’Italia nella classifica del IlMioLibro.it, il portale di Selfpublishing del gruppo Repubblica dove l’avevo lanciato. E come riconoscimento ottenni una periodo di pubblicità gratis sulla Homepege di Repubblica.it
Stava succedendo insomma quello che avevo sempre ipotizzato: più che di un call center dove riversare la bile, le persone avevano bisogno di motivi per sognare, amare, lottare.
Nel mentre cercavo di convincere chi mi amava davvero che lasciare un posto fisso non fosse una cosa da pazzi, ma che la cosa da pazzi fosse restare ancora in un call center a quarant’anni. E che inseguire i miei sogni fosse il gesto più responsabile e altruistico che potessi fare verso di loro e verso me stesso.
Il 1 dicembre 2017, con il cuore in gola, andai a firmare le mie dimissioni. L’unica cosa che mi restava di quindici anni nel call center era mia moglie e il suo amore: conosciuta lì dentro, assunti nello stesso lontano 2003, mi aveva preceduto nella fuga qualche anno prima prendendosi due lauree (una anche al posto mio) e diventando insegnante.
Così in quel breve istante in cui la penna rimase sospesa prima della firma che avrebbe troncato per sempre ogni rapporto con quella che era stata la mia vita sino ad allora, deglutii e ripensai con speranza alla telefonata ricevuta qualche giorno prima: grazie a un’amica illustratrice che aveva ripreso su Instagram una mia poesia, ero stato contattato da un’agente letteraria della Grandi & Associati che aveva voluto sapere tutto di me e mi aveva chiesto un estratto delle mie poesie.
Firmai le mie dimissioni. E sentii in bocca un inedito sapore di libertà, bello e spaventoso insieme.
La sera stessa mi richiamò M. C. Guerra, che oggi è a tutti gli effetti la mia agente, per dirmi che aveva già ricevuto diverse offerte, tra le quali una di quelle a cui difficilmente si può dire di no. La Feltrinelli era interessata alle mie poesie.
Riattaccai, mi sedetti sul divano. Erano passate poche ore dal mio licenziamento. E mi sentivo un po’ come Cenerentola e un po’ come Bukowski dopo una vita all’ufficio postale. Ben sapendo che un invito al gran ballo non avrebbe significato una vita da Re. Ben sapendo che un libro non avrebbe risolto il problema di portare a casa la pagnotta a fine mese, però finalmente con la sensazione di aver trovato il mio posto nel mondo.
Non più dietro un telefono a fingere di assecondare i problemi della gente, ma dentro al mio sogno più grande: provare a risolverli davvero, ma a modo mio, con un poco di poesia.
Chiesi a mia figlia di darmi un pizzicotto. Più forte che riusciva. Ma lei si rifiutò. Mi diede un bacio. E io feci il mio secondo giuramento: allevarla nell’esempio che, al di là della paura, esiste un mondo di opportunità pronto ad attenderci. E per lei, per me, e per tutti, cercai di farmi coraggio.
Andrea Melis – Maggio 2018